Dalla fame del lager al cibo inventato che sazia in un momento
Dall’articolo di «Scientific American» ai racconti di Vizio di forma, Primo Levi riflette sulla fame, forse proprio per averla provata lui stesso e, con un valido monito per il suo tempo e per il nostro, ci suggerisce di riflettere sulle condizioni dell’umanità mondiale, per la quale, specie nelle aree più povere, lo scarso apporto calorico e la carenza di nutrienti fondamentali mettono a serio rischio la salute.
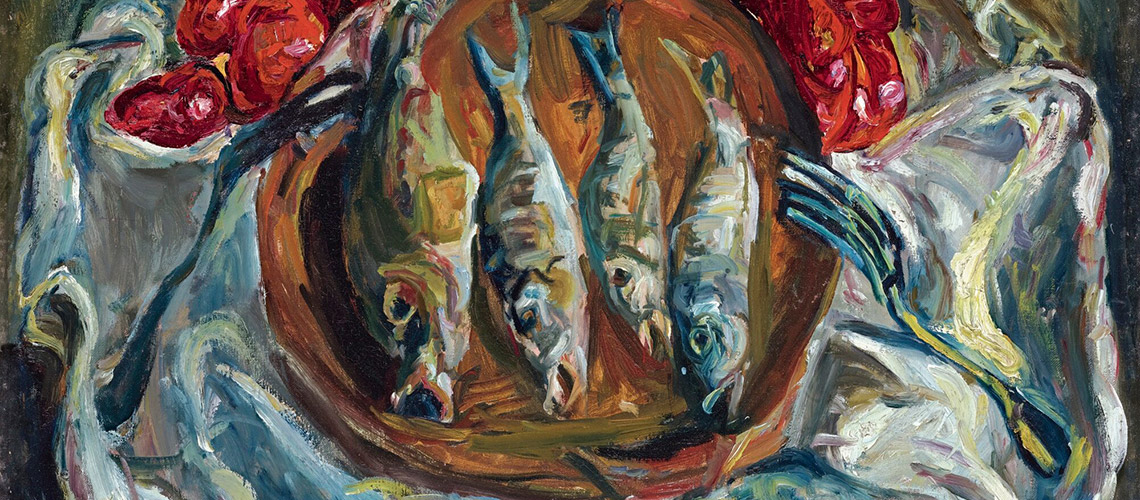
Febbraio 1967: il biochimico inglese Norman Wingate Pirie pubblica su «Scientific American» il saggio Orthodox and Unorthodox Methods of Meeting World Food Needs, dove passa in rassegna i metodi del tempo per fabbricare cibo al fine di soddisfare i bisogni dell'umanità tutta. Egli cita ad esempio l’incaparina, un prototipo di alimento a base di proteine vegetali integrato con vitamine, che assicura un apporto di aminoacidi in linea con quello fornito da proteine animali di buona qualità; si tratta quindi di un alimento in grado di garantire tutti quei nutrimenti necessari al mantenimento in salute delle persone. Il problema infatti principale era: «How to produce enough food in the more populous parts of the world?».
Ancora oggi, più di cinquant’anni dopo, cerchiamo di trovare una risposta a questa domanda. Ottenerla, viste le attuali condizioni storiche, economiche e politiche - ancor di più in presenza della pandemia da Covid - sembra molto difficile: ancora oggi una persona su dieci soffre e muore di fame, ancora oggi non siamo in grado di fornire a ogni essere umano generi di prima necessità.
Se si parla ad esempio di fame è, come dire, una falsa omonimia quella di chiamare con lo stesso nome la fame di chi salta un pasto e la fame di chi vive in un Lager. […] la fame di cui parliamo, non solo io, è la prima, è l'esperienza più dura della prigionia, di quel tipo di prigionia. La fame del Lager è molto difficilmente descrivibile, non dico con quella parola, con la parola fame, ma con qualunque altra parola perché è un'esperienza che pervade dalla testa ai piedi e per tutte le ventiquattr'ore e per mesi e mesi di fila, e diventa una fame ossessiva, una sensazione che non cessa mai anche dopo un pasto e che diventa più psicologica che fisiologica.
(da un intervento del 5/05/1986, nelle Opere complete di Einaudi, vol. 3)
Queste parole sono di Primo Levi, che conosceva bene il disagio della fame. Durante l’internamento in Lager, dal 1944 al 1945, era stato costretto a un regime misero, era diventato uno di quegli scheletri che riempivano e perivano a migliaia tra i reticolati dei Campi della Morte. Pensare che moltissime persone oggi, ora, continuino a vivere questo tormento è aberrante.
È chiaramente una allusione, una visione retrospettiva mia. Comunque non è specifico: a parte il fatto che ho provato la fame, chiunque legga i giornali sa che un terzo del mondo è sottoalimentato. Non credo che occorra essere stati ad Auschwitz perché emerga il problema della fame; non credo che sia un problema specificatamente mio.
Così rispondeva a Paola Valabrega, che gli domandava se la presenza della fame nelle sue opere fosse un «simbolo di una degenerata condizione umana che deriva dall'esperienza dal Lager». Dunque un retaggio, certo, ma non l’unico motivo da cui nasceva la sua produzione letteraria: l’opera di Levi ha una dimensione etica, contiene delle «trappole morali» (come ha sottolineato Federico Pianzola), è una sorta di amuleto-monito che ci fa riflettere su ciò che ci circonda. In particolare due racconti di Vizio di forma, il “dittico Recuenco”, affrontano da vicino la piaga della fame: in un futuro utopico, o in un presente non troppo lontano, un equipaggio internazionale di marinai del cielo gira il mondo su un hovercraft volante e scarica tonnellate di «latte celeste» su tutti i popoli che stentano a sopravvivere.
C'è una foresta sterminata, grande come tutto il Texas, e un super-rafter che va e viene in mezzo. A mano a mano che avanza, falcia tutte le piante davanti a sé, e si lascia dietro una scia vuota larga trenta metri. Le piante vanno a finire dentro la stiva, vengono sminuzzate, cotte, lavate con un acido, e se ne cavano le proteine, che sono appunto il latte; noi lo chiamiamo così, ma il nome ufficiale è FOD. Il resto della pianta serve a fornire energia alla macchina stessa.
(Recuenco: il rafter, in Vizio di forma, 1971)
Secondo Enrico Mattioda, è stato proprio l’articolo di Pirie su «Scientific American» la fonte di ispirazione di Levi. Insieme, ovviamente, all’incubo del Lager: chi altri se non colui che è costretto a vivere in tale condizione inumana, può inventare un cibo sintetico che soddisfi ogni esigenza, che cancelli la fame? Levi cerca rimedi per combattere un male endemico del nostro sovrappopolato e ipersfruttato pianeta: tramite il preparato che i marinai portano nelle zone disagiate della Terra. Per esempio verso il piccolo e recondito villaggio di Recuenco, dove, in mezzo alla penuria e alle mancanze, vivono Sinda, Diuka, Daiapi e altri campagnoli, quelli che chiamano il rafter «Nutrice», che lo venerano perché fornisce loro quel cibo «denso e insipido», che «saziava in un momento». Talmente tanto che alcuni morivano per averne abusato, come i «salvati» dal Lager «invasi da un bisogno ossessivo di mangiare tutto, qualunque cosa venisse presentata, di non lasciare nulla di non mangiato; davanti a tre chili di pane mangiare tre chili di pane».
Grazie alla letteratura e all’ispirazione scientifica, Levi immagina un possibile rimedio: un’organizzazione mondiale che provveda alle mancanze alimentari, che si occupi di garantire all’umanità intera le principali sostanze nutritive (come nell’articolo di Pirie), che si preoccupi di non lasciare mai più nessuno a «lottare per mezzo pane», e chi guarda a chiedersi davvero “se questo è un uomo”.
Nella direzione auspicata da Levi va questo bel progetto di colleghe del dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco che hanno ideato una pasta terapeutica per curare la malnutrizione infantile nei pesi in via di sviluppo.







