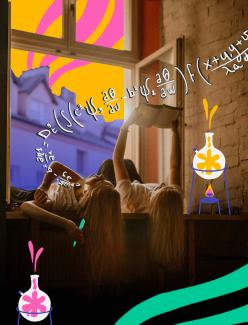Storie sommerse e altri sguardi: il cinema delle migrazioni nel Mediterraneo
Il cinema delle migrazioni non è solo un genere tematico, ma uno spazio culturale e politico in cui si costruisce un altro modo di vedere. In un contesto dominato dalle immagini, è essenziale riflettere non solo su ciò che vediamo, ma su come guardiamo. In controtendenza rispetto ai media mainstream, film come Until He's Back (2023) offrono un cambio di prospettiva, favorendo una comprensione empatica dell’alterità ed evidenziando le interconnessioni che rendono le migrazioni nel Mediterraneo un fenomeno globale.

È un rischio folle quello che ci stiamo prendendo. Ma vogliamo credere che esista una comunità di persone, in Europa e nel Mediterraneo, che come noi sognano che un giorno questo mare smetta di ingoiare le vite dei suoi viaggiatori e torni ad essere un mare di pace, un mare dove tutti siano liberi di viaggiare, e dove nessuno divida più gli uomini e le donne in legali e illegali. Quella comunità esiste.
Gabriele Del Grande
Ahmed Tchiche sa che suo figlio Yahya è deceduto nelle acque insidiose dello Stretto di Gibilterra ma, finché il suo corpo non verrà restituito alla famiglia dal governo spagnolo, non troverà pace. Da questa attesa, lunga otto mesi, prende il titolo Until He's Back (Jacqueline Baylon 2023), un documentario che intreccia le attività di quattro figure chiave nell’ambito del soccorso umanitario rivolto alle persone migranti, per raccontare la particolare vicenda della famiglia Tchiche, che spera di dare a Yahya l’estremo saluto.
Nonostante esista una “mentalità da ONG” incline a rappresentare il continente africano attraverso la lente del vittimismo e del pietismo, come dimostrato da Stop Filming Us (2020) di Joris Postema,
Until He's Back è un esempio di rappresentazione che evita tanto l’approccio umanitario, quanto lo sguardo alterizzante, che è basato sulla differenziazione tra “noi” e “loro” e messo in evidenza negli studi, in primis, di Frantz Fanon (Pelle nera, maschere bianche 2015) ed Edward Said (Orientalismo 2013). Il documentario, invece, pone in dialogo le difficoltà vissute dalle ONG spagnole e dalle famiglie in Marocco nel rintracciare le persone disperse in mare, restituendo agency e complessità alla controparte non europea.
Per quaranta minuti di durata, il film segue alcuni momenti della quotidianità di un volontario e di un’operatrice del Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos di Malaga, di un impresario di pompe funebri ad Algeciras e di un capitano nelle missioni della Open Arms. Questa scelta narrativa fa sì che, dall’intimità della vicenda familiare, vengano evocate tutte le storie sommerse sulla sorte incerta di coloro che tentano la pericolosa traversata del Mar Mediterraneo a bordo di imbarcazioni precarie.
Candidato finalista per la 97° edizione degli Academy Awards (2025), Until He's Back si affianca ai molti altri film che, negli ultimi quindici anni, hanno raccontato le rotte migratorie del Mediterraneo verso i confini europei. Tra questi ricordiamo i più recenti Mothership (Muriel Cravatte 2024) e Save Our Souls (Jean-Baptiste Bonnet 2024); Sconosciuti Puri (Valentina Cicogna, Mattia Colombo 2023) dedicato all’identificazione dei corpi annegati; Io capitano di Matteo Garrone (2023) sul viaggio che precede l’approdo in Europa; e ancora, sulle operazioni di salvataggio, Purple Sea (Amel Alzakout, Khaled Abdulwahed 2020), Eldorado (Markus Imhoof 2018), Iuventa (Michele Cinque 2018) e il pluripremiato Fuocoammare (Gianfranco Rosi 2016); e poi Mediterranea (Jonas Carpignano 2015), Mare chiuso (Stefano Liberti, Andrea Segre 2012) e Terraferma (Emanuele Crialese 2011) che portano sullo schermo i chiaroscuri dell’accoglienza europea.
LEGGI ANCHE
Attraversare il trauma della migrazione con la letteratura
Questi sono alcuni dei film analizzati nel progetto di ricerca dottorale “Migrant Mediascapes. Il cinema delle migrazioni come medium della comprensione interculturale nel patrimonio filmografico italiano e tedesco (2011-2026)”, che prende in esame la dimensione simbolica e immaginaria del cinema delle migrazioni e fa parte delle attività del Gruppo di Ricerca “Global Media Aesthetics Studies (GloMAS)”.
Se oggi si parla di un vero e proprio “cinema delle migrazioni” è perché la sua recente prolificità ha segnalato l’urgenza di affrontare un tema complesso e globale che, oltre a riguardare la mobilità delle persone, richiama al centro del dibattito culturale la relazione tra identità e alterità e la questione politica dell’immagine, o la questione della politica delle immagini (Georges Didi-Huberman, Quando le immagini prendono posizione 2009).
La preminenza data alle immagini, nella contemporanea cultura visuale, se da un lato rischia di rendere invisibile ciò che è sovra-rappresentato, dall’altro evidenzia l’importanza della qualità dello sguardo nella creazione di una prospettiva sul mondo.
Dal momento che le immagini audiovisive non si limitano a raccontare la realtà, ma influenzano ciò che pensiamo e le scelte che compiamo, quello che vediamo e condividiamo nell’era digitale genera effetti difficili da prevedere (Arjun Appadurai, Modernità in polvere 2001).
Contraddistinta da fluidità e liquidità (come osserva Zygmunt Bauman in Modernità liquida, 2012), l’epoca globale è attraversata da un intreccio di transiti materiali e immateriali che non può più essere districato. Alla mobilità degli individui e delle merci si affiancano i flussi simbolici della cultura che i media diffondono e moltiplicano.
In questa rete di interconnessioni, studiosi come Thomas Nail (The Figure of the Migrant 2015) propongono di considerare la figura migrante come una chiave di lettura privilegiata dell’epoca globale, contraddistinta dal movimento. Una delle voci di Until He's Back, Martín Zamora, osserva:
"Non è né logico, né giusto che io possa andare in Marocco in vacanza con il mio passaporto, mentre con il passaporto marocchino non si possa venire in Spagna in vacanza o a cercare lavoro".
Questa asimmetria richiama la distinzione proposta da Bauman tra “turisti” e “vagabondi”: i primi si muovono per scelta, i secondi perché non hanno alternativa.
I “vagabondi”, inoltre, "sono viaggiatori cui si nega il diritto di diventare turisti. Non possono stare in pace - non ci sono luoghi che garantiscano loro la permanenza, la fine di una mobilità non voluta - né andare a stare in un posto migliore".
(Dentro la globalizzazione 2001, p. 104).
Eppure, sono proprio i “vagabondi” gli uomini e le donne che riorganizzano la geopolitica globale. E il cinema, raccontando ciò che resta ai margini dell’agenda politica e mediale, può rappresentare uno dei terreni più fertili per promuovere una comprensione empatica dell’alterità e far affiorare, dallo sguardo non indifferente, una solidarietà fondata sulla condivisione di una condizione umana comune, unitaria e molteplice.
Until He's Back si inserisce in questa riflessione più ampia e trasforma l’attesa di un corpo in una metafora della condizione migrante: sospesa tra confini e legislazioni, tra l’inclusione e l’esclusione, tra la memoria e l’oblio.
Bibliografia
Arjun Appadurai, Modernità in polvere, Roma: Meltemi, 2001.
Zygmunt Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Bari: Laterza, 2001.
Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Bari: Laterza, 2012.
Gabriele Del Grande, Campagna di crowdfunding per Io sto con la sposa
Georges Didi-Huberman, Quando le immagini prendono posizione. L’occhio della storia I, Milano-Udine: Mimesis, 2009.
Umberto Eco, Migrazioni e intolleranza, Milano: La nave di Teseo, 2019.
Frantz Fanon, Pelle nera, maschere bianche, Pisa: ETS, 2015.
Stuart Hall, Il soggetto e la differenza. Per un'archeologia degli studi culturali e postcoloniali, Roma: Meltemi, 2006.
Laurie Ouellette e Jonathan Gray, Parole chiave per i media studies, Roma: Minimum Fax, 2018.
Thomas Nail, The Figure of the Migrant, Stanford (California): Stanford University Press, 2015.
Edward Said, Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente, Milano: Feltrinelli, 2013.