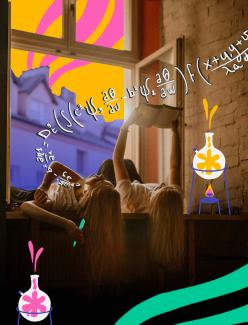L’educazione delle persone migranti. Storia delle scuole italiane in Argentina
L'educazione delle persone migranti rappresenta un tema di grande rilevanza per le società contemporanee, ma che affonda le radici nel passato. A partire dal 1867, a Buenos Aires, delle associazioni italiane di mutuo soccorso aprirono le prime scuole per trasmettere lingua e cultura italiana. Queste istituzioni rimasero attive fino al 1943. Studiare la loro storia ci aiuta a rileggere il presente: capire come la scuola ha affrontato l’educazione delle persone migranti nel passato può offrirci strumenti per affrontare le sfide educative di oggi.

Roberto Antonio Serrao, mio nonno, nacque a Buenos Aires nel 1915 all’interno di una famiglia calabrese emigrata in Argentina nel 1885. Secondo la leggenda famigliare, da bambino il piccolo Roberto veniva preso in giro dai suoi fratelli maggiori per essere l'unico "non italiano", cioè l'unico nato in Argentina. Stufa delle liti, la mia bisnonna, Maria Calfapietra, un giorno decise di ricamare sulle cinghie dei pantaloncini del figlio minore la scritta Roberto Serrao è italiano. Non so se questo gesto riuscì a placare i bambini, ma so per certo che con il passare del tempo mio nonno smise di dare peso alla questione. Anche se l’eredità calabrese rimase sempre presente nella sua vita, Roberto Antonio giunse alla conclusione che l'Italia era la patria dei suoi genitori, ma non la sua. Lui era argentino.
Roberto José, mio padre, racconta che solo una volta lo sentì parlare in italiano, che le associazioni etniche non gli interessavano affatto e che durante le partite di calcio tra Argentina e Italia non aveva dubbi nel tifare per il suo paese di nascita. E anch’io lo ricordo così.

Lontana dall’essere straordinaria, la storia di mio nonno si inserisce perfettamente nel fenomeno che lo storico Fernando Devoto considera caratteristico delle migrazioni italiane in Argentina (che tra il 1830 e il 1950 coinvolsero circa 3 milioni e mezzo di persone):
a differenza di altri contesti di arrivo, come gli Stati Uniti, le figlie e i figli, così come le e i nipoti delle persone migranti, raramente si sentono al cento per cento "italiane" o "italo-argentine". Sebbene la cultura dei genitori permei le loro abitudini alimentari, il loro modo di parlare e il loro familismo – cioè l’importanza attribuita ai legami familiari –, il loro punto di riferimento è quasi sempre l’Argentina.
Tra i vari fattori che spiegano questa particolarità c’è l'influenza della scuola pubblica argentina, che insegnò alle cosiddette seconde e terze generazioni di migranti a sentirsi argentini e argentine. Come ci hanno insegnato diversi autori, tra cui Eric Hobsbawm e Benedict Anderson, le nazioni non sono entità oggettive e naturali, ma costruzioni storiche e sociali. Per cui, il senso di appartenenza a una nazione è più “imparato” che “naturale”, e per questo motivo la scuola ha funzionato come un potente agente di nazionalizzazione.
Ma i figli e le figlie dei migranti non frequentavano solo scuole pubbliche. Sin dagli anni ’60 dell’800, infatti, diverse associazioni italiane di mutuo soccorso istituirono scuole elementari per trasmettere l’identità italiana o una sua interpretazione. Pur coinvolgendo un piccolo numero di studenti e studentesse, questi progetti suscitarono forti critiche da parte di molti nazionalisti argentini, i quali li percepivano come una minaccia alla costruzione dell'identità nazionale argentina e alla "assimilazione" dei migranti in un’identità nazionale predefinita.
Queste critiche, però, spesso venivano strumentalizzate a fini politici, lasciando aperti numerosi interrogativi per la ricerca storico-educativa: Qual era lo scopo delle scuole italiane? Chi veniva coinvolto nel progetto educativo? Come interpretavano l’italianità? E l’argentinità? Qual era il loro modello di cittadino e di cittadina? Come influì la Grande Guerra sull'insegnamento? E l’arrivo del fascismo?
Nella mia tesi di dottorato ho cercato di rispondere a queste domande, consultando diversi archivi italiani e argentini che hanno permesso di ricostruire le trasformazioni e le sfumature del progetto educativo italiano. Discussa nel 2024, la tesi si proponeva di colmare, seppur parzialmente, la significativa lacuna storiografica relativa a queste scuole. Tuttavia, permangono ancora numerosi aspetti da esplorare, come le esperienze delle scuole italiane in altre province argentine tra cui Santa Fe, Buenos Aires e Córdoba. È fondamentale anche ampliare l'orizzonte di ricerca verso altri contesti migratori e coloniali, al fine di sviluppare gli studi transnazionali sulla scuola italiana all'estero, la quale ha assunto forme diverse a seconda delle specifiche realtà di accoglienza. Il volume "Istituzioni educative italiane in contesti migratori e coloniali (sec. XIX-XX)", che ho curato insieme a Francesco Pongiluppi, rappresenta un passo in questa direzione, raccogliendo i contributi di ricercatori e ricercatrici sulle scuole italiane in varie parti del mondo, dalla Siria al Brasile, dalla Germania alla Tunisia.
Tornando al caso di Buenos Aires, la mia ricerca ha ricostruito una pluralità di iniziative educative italiane che, nel corso di quasi un secolo, si sono evolute insieme alla storia dei due Paesi. Tra queste, mi ha particolarmente colpito un progetto sviluppato negli anni ‘80 dell’800, che in un certo modo discuteva l’approccio di “assimilazione” dello Stato argentino – cioè la tendenza a voler integrare le persone migranti eliminando le differenze culturali –
suggerendo un modello educativo che valorizzasse l’origine delle famiglie migranti attraverso un curriculum “misto”. L’idea di fondo era che fosse possibile far parte di una società senza dover rinunciare al proprio bagaglio culturale.
Tra la fine dell'800 e l'inizio del ‘900, l'emergere del nazionalismo italiano ebbe ripercussioni negative su questo progetto, il quale svanì con l'ascesa del fascismo. Negli anni ‘30, in particolare, il regime tentò di utilizzarlo come un mezzo per diffondere la propria ideologia. La maggior parte delle scuole italiane a Buenos Aires abbracciò un nazionalismo colonialista, interpretando la realtà sudamericana come un territorio culturalmente inferiore.
LEGGI ANCHE
Attraversare il trauma della migrazione con la letteratura
Pur senza considerare la Storia come maestra di vita, credo che ci offra strumenti preziosi per leggere le trasformazioni delle nostre società nel tempo. In un presente segnato da migrazioni in crescita, nazionalismi sempre più aggressivi e modelli socio-economici e culturali che marginalizzano ampie fasce della popolazione, è urgente tornare a interrogarsi sulle esperienze del passato.
Le analisi storiche sul ruolo della scuola nei contesti migratori ci invitano a confrontarci e comprendere le sfide attuali e a immaginare la società che desideriamo costruire. è questo l’orizzonte di riflessione che guida il gruppo di ricerca MESCLA (Migrazioni, Educazione, Storia, Cittadinanza, Lavoro, Adultità), dove studiamo il rapporto tra educazione e migrazione come chiave per analizzare il passato, leggere il presente e pensare il futuro.
1 F. Devoto, Le migrazioni italiane in Argentina: il problema dell’identità, delle migrazioni e del contesto, in M. Tirabassi (a cura di), Itinera. Paradigmi delle migrazioni italiane, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino 2005, p. 332.
Testi di approfondimento
Devoto, Fernando, Storia degli italiani in Argentina, Roma, Donzelli, 2007
Pongiluppi, Francesco – Serrao, Paula Alejandra (a cura di), Istituzioni educative italiane in contesti migratori e coloniali (sec. XIX-XX), Franco Angeli, Milano, 2024.
Serrao, Paula Alejandra, «¿Qué es eso, pues, de educar italianamente?» Le scuole italiane a Buenos Aires, tra idealità nazionalistiche ed effettivi processi scolastici (1867-1943). Tesi di dottorato, Università di Torino, Dottorato in Scienze pedagogiche, antropologiche e dell’educazione, ciclo XXXV, Tutor Paolo Bianchini, 2024. Tesi Paula Alejandra Serrao.pdf