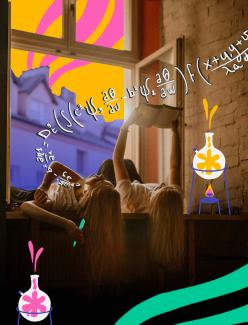Straniero a chi? La cittadinanza attiva della gioventù islamica italiana
Le cosiddette “seconde generazioni” (figlie e figli di persone migrate in Italia) interessano la politica, i media e, naturalmente, la ricerca scientifica. Coetanei e coetanee di diverse convinzioni e fedi religiose – musulmane, atee, agnostiche, buddhiste, protestanti e ortodosse – condividono percorsi di crescita e scoperta di sé anche se spesso subiscono un odio legato alla fede che professano (o che non professano, ma che gli viene incollata addosso). La loro storia è comparabile a quella di altre minoranze, come la comunità evangelica argentina, che il nostro progetto intende studiare mettendo a confronto le forme di regolazione, riconoscimento o restrizione delle religioni, e individuando gli elementi più efficaci per favorire l’inclusione.

[N.d.R.] Questo racconto è stato scritto per Frida da Luca Bossi pochi giorni prima della sua scomparsa. Lo pubblichiamo perché valorizzare il suo lavoro di ricerca è il nostro modo per onorare la sua memoria.
In un’epoca in cui l’integrazione e la convivenza tra culture diverse sono temi sempre più discussi, sorgono quasi naturalmente alcune domande: qual è la condizione delle minoranze etniche e religiose in Italia? Quali rapporti hanno avuto e hanno oggi con la società? Perché la libertà religiosa è un principio cardine delle nostre democrazie? E perché abbiamo bisogno di politiche di integrazione e inclusione?
A queste e altre domande cerca delle risposte il progetto L’identità religiosa in emigrazione. Una ricerca comparata fra Europa e America, finanziato dal Programma di Cooperazione Bilaterale promosso da CONICET (Consejo Nacional De Investigaciones Cientificas y Técnicas) di Buenos Aires e CUIA (Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina). Il team di ricerca è composto da Luca Bossi (UNITO), María Pilar García Bossio, Marcos Andres Carbonelli e Mariela Analia Mosqueira (CONICET), con il coordinamento di Juan Cruz Esquivel (CONICET) e Roberta Ricucci (UNITO).

La ricerca ha l’obiettivo di studiare il rapporto tra le dinamiche migratorie e la condizione delle minoranze etno-religiose, nel passato e nel presente.
Insieme alle colleghe e ai colleghi del CONICET, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla condizione attuale delle comunità islamiche in Italia e di quelle evangeliche in Argentina, analizzando le differenze e le similitudini nelle difficoltà – culturali, economiche, giuridiche, sociali e politiche – che queste minoranze incontrano per raggiungere il riconoscimento giuridico e sociale. Attraverso il confronto, sono emersi alcuni temi comuni, come l'egemonia storica della confessione prevalente e l'approccio statale securitario alla diversità religiosa. Sono emerse anche differenze, come la sostanziale assenza di islamofobia nel caso argentino e una regolazione particolarmente restrittiva delle moschee in Italia, che non ha corrispettivi con il caso delle chiese evangeliche in Argentina.

Nonostante ciò, le nostre ricerche mostrano come, già durante il Risorgimento, in Italia giovani generazioni di cattolici, ebrei e protestanti abbiano contribuito insieme alla rinascita del paese, suggerendo che dalla pluralità religiosa possano scaturire cambiamenti positivi.
Le prime persone di fede musulmana immigrate nel nostro paese, in buona parte giovani universitari dai paesi del Medio Oriente, arrivarono a partire dagli anni ’70. Oggi, la componente islamica della popolazione si aggira intorno ai 2,5 milioni di persone, circa il 4% dei residenti totali. Si tratta di un dato ben distante dalla percezione diffusa e dall’immaginario dell’invasione e della sostituzione etnica troppo spesso veicolato dalla comunicazione politica e mediatica, ed è inoltre un dato sovrastimato, perché include neonati e minorenni e non distingue tra chi pratica l'islam regolarmente e chi ne fa parte solo a livello culturale o familiare, o non pratica affatto.

La popolazione islamica italiana rappresenta un panorama variegato di culture, lingue, dialetti, tradizioni e abitudini religiose da cui sono nate comunità che si sono dotate di moschee e altri luoghi di ritrovo, conforto e condivisione.
A distanza di cinquant’anni da quelle prime migrazioni, le persone di fede islamica in Italia sono parte integrante della demografia nazionale, anche se ancora vittime di discriminazioni politiche e mediatiche – in primis sulle piattaforme social – di origine islamofoba.
Contro l’islam si spendono campagne elettorali e proposte di legge come quelle per mettere al bando le moschee. Si tratta di iniziative che non si registravano in Italia dai tempi della propaganda antisemita e delle leggi razziali che in epoca fascista hanno colpito le comunità ebraiche italiane.
In questo contesto, è particolarmente interessante studiare la condizione delle persone nate o cresciute in Italia da genitori con background migratorio, che condividono con le generazioni precedenti il peso di stereotipi e pregiudizi. Queste sono spesso trattate come straniere nella loro stessa patria, per via del colore della pelle o dell’origine famigliare, e devono fare i conti con lo stigma legato a una fede che diventa bersaglio di sospetto e ostilità da parte della società.

Perciò, nell’ultima parte di questa ricerca ci concentriamo sui diversi aspetti della vita della gioventù musulmana italiana, con particolare attenzione alle esperienze di discriminazione ed esclusione anche sul piano socio-economico. La nostra analisi si focalizza in particolare sul ruolo sociale delle nuove generazioni: partecipazione a gruppi giovanili e associazioni di volontariato (religiose, laiche, miste), percorsi di cittadinanza attiva e di impegno civico, inserimento nel mercato del lavoro e il ruolo di ponte che svolgono nei confronti delle istituzioni pubbliche.
Torino è, da questo punto di vista, un caso empirico rilevante: nonostante le disparità socio-economiche tra i suoi quartieri, la città ha saputo promuovere politiche pubbliche e pratiche quotidiane di integrazione e inclusione, che hanno permesso di riconoscere le moschee e metterle in dialogo con le altre confessioni, consolidando un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione tra le comunità islamiche, le istituzioni locali e il tessuto associativo, culturale e produttivo.
Come emerge dalla ricerca L’identità religiosa in emigrazione, il caso torinese rappresenta un esempio positivo di politiche di inclusione, che può contribuire a migliorare la convivenza tra identità, anche in altri contesti urbani.
Sarà importante scoprire quanta parte di quel mutuo investimento, delle e sulle prime generazioni, tornerà a noi tutti attraverso le seconde e le terze, in termini di capitale culturale, economico e sociale: una storia che sta già avvenendo, e che saremo pronte e pronti a raccontare.